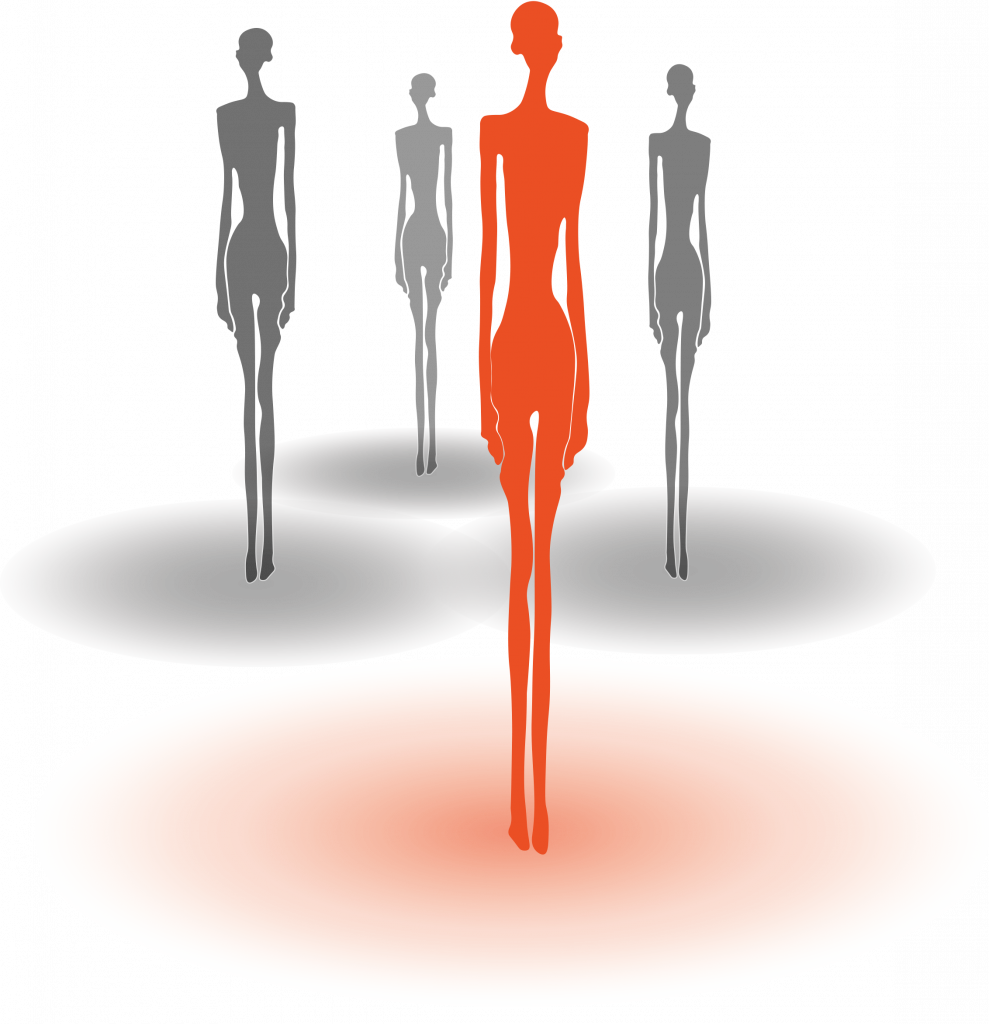
Perceiving Space Differently
The body and the invisible dimension of space
Published in October 2025
Imagine lying in a meadow, far from everything. You close your eyes, the grass brushes your arms, the sun caresses your skin. A moment of pause in which it is only you and the rustling of the leaves in the trees. The world seems suspended in a perfect balance where you are the master of your space, and your senses are heightened. Then, in the distance, you feel a presence approaching. The meadow is vast, boundless, yet that person chooses to stop just a few steps away from you. Not close enough to speak, yet not far enough to ignore. Apparently, nothing has happened, and yet that balance is suddenly broken. The space you had just felt as yours, intimate and safe, has been altered. Even though that person has done nothing wrong, they have unintentionally disrupted a sensory and perceptive equilibrium that had been established between you and space. Without knowing it, they have crossed an invisible yet concrete boundary: your personal space. Spaces are not neutral, and they are not only external. They extend beyond the skin, beyond the body, into a very delicate threshold between oneself and the world.
#Body #Space #Intangible
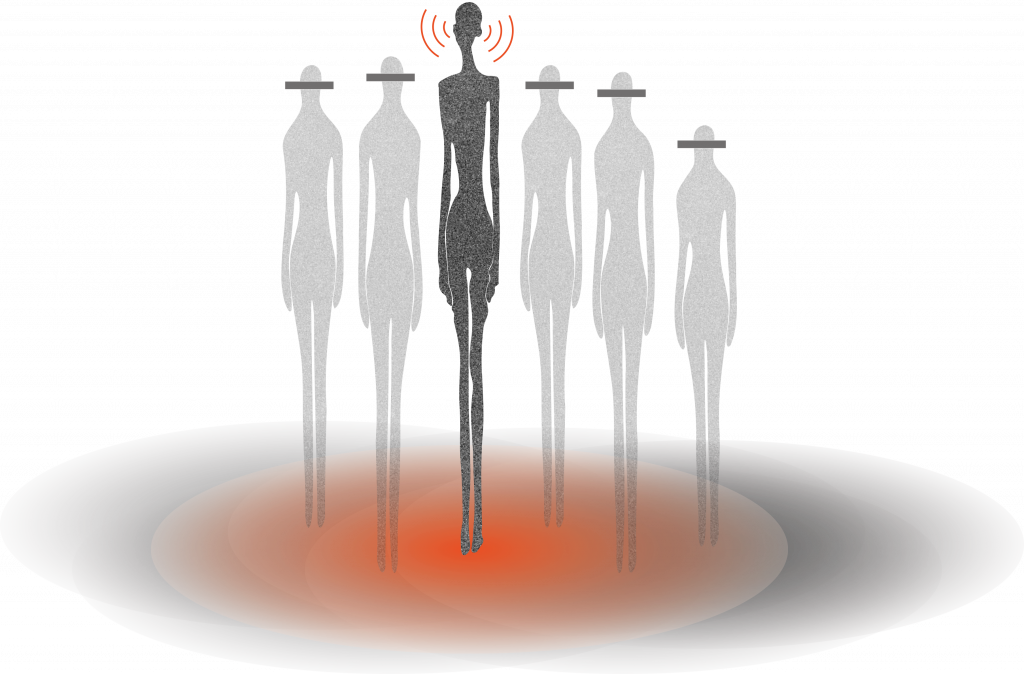
A small event that can reveal much about how we experience places and how personal that experience is, through subtle perceptions, immediate emotions, and resonances that our body senses even before they can take shape as thoughts. This also shows how space is never neutral, but rather an interweaving of subtle perceptions, immediate emotions, and bodily resonances that extend beyond individual boundaries. From this perspective, we can interpret the act of “inhabiting” through everyday gestures, memories, habits, and affections that shape places. Perception is the spontaneous and immediate experience; observation, instead, is intentionality, arising from the will to analyze and interpret what has been perceived. It is the same gaze that, in the first cycle of Urbinary, the episode “Rethinking Observation in Urban Studies” invites us to rethink observation as a conscious presence that, just like in the meadow, influences and is in turn influenced by one’s own position in space, sometimes intangible, invisible.
Space is perceived both physically and inwardly, yet we rarely become aware of it. Whether conscious or not, space takes shape from our lived experience through it. Walking, avoiding, running, stopping, observing, ignoring, listening, understanding…every daily gesture is steeped in a relationship with space, which is at once a symbolic practice, spontaneous, and involuntary. Expectations, habits, affections, memories: all these shape the way we move through places.
As Georges Perec writes that the inhabitants of the same building live just a few centimeters apart, separated by a simple partition, and they share the same spaces repeated floor by floor, performing the same gestures at the same time (Perec, 1989). Just like Georges Perec, Cristina Bianchetti, professor at the Faculty of Architecture at the Polytechnic University of Turin, in her book Bodies Between Space and Design, reminds us that space is never a neutral container; on the contrary, it is living matter that we feel in our flesh. It is something that passes through us, and that we in turn traverse. Indeed, it is thanks to our sensitive, reactive, vulnerable body that an authentic relationship with the environment is created. Nevertheless, this kind of perception often remains invisible, marginal, and excluded from the official narratives of design.
Gloria Calderone, researcher and designer, in her doctoral thesis, Human Spaces and Urban Bodies. Artistic and Performative Approaches for a Re-Signification of Habitable Places has deeply investigated precisely this “unseen.” Her theory revolves around the relationship between space and body, placing the body as an active subject of knowledge and transformation. In her studies, she writes about artistic and performative practices as tools to restore sensitivity to urban spaces that have been anesthetized. In other words, urban spaces, dominated by scientific rationality, tend to ignore the body and sensory experience, rendering urban space sterile and unfeeling. In these practices, the body becomes a lens through which to read and re-signify place, connecting sensory perception with memory, emotions, and, at the same time, with the power structures that silently govern our urban experience.

Visual metaphor of the denied urban body, like an object that is present but imprisoned, inaccessible. The bodily experience is reduced to an image. The city thus becomes something to be looked at from afar, with no possibility of interaction.
This awareness, however, rarely accompanies our daily gestures. Yet we seldom pause to reflect on how those spaces make us feel. Why do we choose a tree-lined street instead of one without greenery? Why do we prefer to sit on the grass rather than on a concrete bench? These seemingly banal questions lead us to recognize that every place touches our body in different ways, and that these gestures, however silent, are often decisive in our inhabiting. Barbara Piga and Eugenio Morello (Piga & Morello, 2015) better explain this concept in their study on environmental design and perceptual simulation. Their work shows that our experience of space is fundamentally multisensory. Sight, sound, touch, temperature, and even the subtle sense of our body moving through the environment interact to shape perception. They describe perceptual simulation to anticipate and engage with spaces, highlighting that our body is always active in interpreting what surrounds us. Even the smallest gestures, like choosing a shaded path or sitting on the grass, become part of this dynamic interplay between body, perception, and space.
If our first relationship with space is sensory, and therefore we feel it (in the sense of perceiving) even before seeing it, then why do those who design spaces continue to privilege vision as the main channel of interpretation and representation? Space is an experience that cannot be reduced to its mere image; it must be lived firsthand, with awareness.
Thus, Calderone and Bianchetti invite us to shift our attention to the invisible: sounds, smells, atmospheres, voids, and pauses. For example, if we isolate hearing, we can listen to what space gives back to us, transforming the frequencies we hear into emotional, social, or political vibrations. Even silence speaks of exclusion, of power, of boundaries.
Calderone proposes the concept of an ethics of space through aesthetics: “It is not only about beauty and aesthetic taste (all about the visual field), which designers and planners already know well, but about the sensitive, emotional, symbolic, and affective dimension that is an integral part of existence” (Calderone, 2024). Hence, an ethical aesthetics of perception: to design means to take responsibility for embracing the diversity of bodies and experiences, to recognize as legitimate the “other” ways of inhabiting. If we design only for what is visible and measurable, we end up ignoring what is essential yet intangible: desires, needs, memories. Thus arises a question: how can the invisible be made visible? To inhabit consciously means, above all, learning to listen, and therefore we must become skilled listeners to truly perceive our body, its needs, its discomforts, its invisible attractions. It means realizing that space is never neutral, and that every gesture, even the most automatic, tells something about our way of being in the world.
I believe that cultivating this attentiveness is today more necessary than ever, in a city increasingly standardized, functional, and fast. To inhabit does not mean using space, but to feel that one belongs to it, even if only for an instant. A form of care, of presence, of responsibility. Reclaiming this sensitivity means reclaiming the capacity for relationships, and it can become a political act. A way of bringing bodies, sensations, and stories — those that pass unnoticed every day but that are the true matter of the city — back to the center.
Text in Italian
Immagina di essere sdraiata in un prato lontano da tutto. Chiudi gli occhi, l’erba ti sfiora le braccia, il sole accarezza la pelle. Un momento di pausa in cui sei solo tu e il fruscio delle foglie sugli alberi. Il mondo sembra sospeso in un equilibrio perfetto dove sei padrona del tuo spazio e i sensi si amplificano.
Poi, in lontananza senti una presenza avvicinarsi. Il prato è enorme, sconfinato, ma quella persona sceglie di fermarsi proprio a pochi passi da te. Non abbastanza vicino da parlarsi, ma nemmeno abbastanza lontani da ignorarsi. Apparentemente non è successo nulla, eppure quell’equilibrio improvvisamente si interrompe. Lo spazio che poco prima sentivi tuo, intimo e sicuro, è stato alterato. Nonostante quella persona non abbia fatto nulla di male, involontariamente, ha interrotto un equilibrio sensoriale e percettivo che si era costruito tra te e lo spazio. Senza saperlo, ha violato un confine invisibile, ma concreto: il tuo spazio personale. Gli spazi non sono neutri, e non sono solo esterni. Si estendono oltre la pelle, oltre il corpo, in una soglia delicatissima tra sé e il mondo.
Un piccolo evento che può raccontare molto di come sentiamo i luoghi e di quanto sia personale l’esperienza, tramite percezioni sottili, emozioni immediate, risonanze che il nostro corpo avverte prima ancora che possano formularsi come pensieri.
Questo breve episodio mostra come lo spazio non sia mai neutro, ma intreccio di percezioni sottili, emozioni immediate e risonanze corporee che si estendono oltre i confini individuali. A partire da questa visione, possiamo tradurre il gesto di “abitare” attraverso gesti quotidiani, memorie, abitudini e affetti che plasmano i luoghi. La percezione è l’esperienza spontanea e immediata, l’osservazione è intenzionalità che deriva dalla volontà di analizzare e interpretare quel ‘percepito’. È lo stesso sguardo che, nel primo ciclo di episodi di Urbinary “Rethinking Observation in Urban Studies”, invita a ripensare l’osservazione come presenza consapevole che, come nel prato, influenza e viene influenzata dalla propria presenza nello spazio, talvolta intangibile, invisibile. Lo spazio viene percepito tanto fisicamente quanto interiormente, ma solo di rado ne siamo consapevoli. Coscienti o meno, lo spazio prende forma a partire dalla nostra esperienza attraverso di esso. Camminare, evitare, correre, fermarsi, osservare, ignorare, ascoltare, comprendere… ogni gesto quotidiano è impregnato di una relazione con lo spazio, ed esso è al tempo stesso pratica simbolica, spontanea e involontaria. Aspettative, abitudini, affetti, memorie: tutto ciò plasma il modo in cui attraversiamo i luoghi.
Come scrive Georges Perec: “Gli abitanti di uno stesso edificio vivono a pochi centimetri di distanza, separati da un semplice tramezzo, e condividono gli stessi spazi ripetuti di piano in piano, fanno gli stessi gesti nello stesso tempo…” (Perec, G., 1989).
Così come George Perec, Cristina Bianchetti, docente alla facoltà di architettura del Politecnico di Torino, nel suo libro “Corpi tra spazio e progetto” ci ricorda che lo spazio non è mai un contenitore neutro, al contrario è materia viva che sentiamo nella carne. È qualcosa che ci attraversa e che noi attraversiamo a nostra volta. Infatti, è grazie al nostro corpo sensibile, reattivo, vulnerabile, che si crea una relazione autentica con l’ambiente. Ciononostante, questo tipo di percezione resta spesso invisibile, marginale, esclusa dalle narrazioni ufficiali del progetto.
Gloria Calderone, ricercatrice e progettista, nella sua tesi di dottorato “Spazi umani e corpi urbani. Approcci artistico-performativi per una risignificazione dei luoghi dell’abitare” ha indagato a fondo proprio questo “non visto”. La sua teoria ruota attorno alla relazione tra spazio e corpo, ponendo il corpo come soggetto attivo di conoscenza e trasformazione. Nei suoi studi scrive di pratiche artistiche e performative come strumenti per restituire sensibilità agli spazi urbanamente anestetizzati. Ovvero, gli spazi urbani sono dominati dalla razionalità scientifica, tendono a ignorare il corpo e l’esperienza sensoriale, rendendo lo spazio urbano sterile e insensibile.
In queste pratiche, il corpo diventa una lente attraverso cui leggere e risignificare il luogo, connettendo la percezione sensoriale alla memoria, alle emozioni, e contemporaneamente anche alle strutture di potere che silenziosamente governano la nostra esperienza urbana.
Questa consapevolezza, tuttavia, raramente accompagna i nostri gesti quotidiani. Eppure, difficilmente ci fermiamo a riflettere su come quegli spazi ci fanno sentire. Perché scegliamo una alberata invece di una senza verde? Perché preferiamo sederci sull’erba, anziché su una panchina di cemento? Queste domande, in apparenza banali, ci portano a riconoscere che ogni luogo tocca il nostro corpo in modi diversi e che questi gesti, per quanto silenziosi, sono spesso decisivi nel nostro abitare.
Barbara Piga e Eugenio Morello (2016) spiegano meglio questo concetto nel loro studio sul design ambientale e sulla perceptual simulation. Il loro lavoro mostra che la nostra esperienza dello spazio è fondamentalmente multisensoriale. Vista, suono, tatto, temperatura, persino la sottile percezione del nostro corpo in movimento nell’ambiente: tutti questi elementi interagiscono per plasmare la percezione. Essi descrivono la perceptual simulation come uno strumento per anticipare e interagire con gli spazi, sottolineando che il nostro corpo è sempre attivo nell’interpretare ciò che lo circonda. Anche i gesti più piccoli, come scegliere un percorso all’ombra o sedersi sull’erba, diventano parte di questo dinamico intreccio tra corpo, percezione e spazio.
Se il nostro primo rapporto con lo spazio è sensoriale, e quindi lo sentiamo (nel senso di percepire) ancor prima di vederlo, allora perché chi progetta i medesimi spazi continua a privilegiare la vista come canale principale di lettura e rappresentazione? Lo spazio è un’esperienza non riducibile alla sua sola immagine, va vissuto in prima persona, con consapevolezza. Dunque, Calderone e Bianchetti ci invitano a spostare l’attenzione sull’invisibile: suoni, odori, atmosfere, vuoti e pause. Ad esempio, se isoliamo l’udito, possiamo ascoltare ciò che uno spazio ci restituisce trasformando le frequenze ascoltate in vibrazioni emotive, sociali o politiche. Anche il silenzio parla: di esclusione, di potere, di confine.
Calderone propone il concetto di etica dello spazio attraverso l’estetica, “Non si tratta solamente della bellezza e del gusto estetico (tutto afferente al campo visivo) che progettisti e pianificatori conoscono già bene, ma della dimensione sensibile, emozionale, simbolica e affettiva che è parte integrante dell’esistenza” (Calderone G., 2024). Dunque, un’estetica etica della percezione: progettare significa assumersi la responsabilità di accogliere la diversità dei corpi e delle esperienze, riconoscere come legittimi i modi “altri” di abitare. Se progettiamo solo per ciò che è visibile e misurabile, finiamo per ignorare ciò che è essenziale ma non tangibile: i desideri, le necessità, le memorie… Sorge quindi una domanda: come rendere visibile l’invisibile? Abitare consapevolmente significa prima di tutto imparare ad ascoltare, allora bisogna diventare abili lettori. Ascoltare il proprio corpo, i suoi bisogni, i suoi disagi, le sue attrazioni invisibili. Significa rendersi conto che lo spazio non è mai neutro, e che ogni gesto, anche il più automatico, racconta qualcosa del nostro modo di stare al mondo.
Credo che allenare questa attenzione sia oggi più che mai necessario, in una città sempre più standardizzata, funzionale, veloce. Abitare non è consumare spazi, ma sentire di appartenervi, anche solo per un istante. Una forma di cura, di presenza, di responsabilità. Riappropriarsi di questa sensibilità significa capacità di relazione e può diventare un gesto politico. Un modo per rimettere al centro i corpi, le sensazioni, le storie che ogni giorno passano inosservate, ma che sono la vera materia di cui è fatta la città. Allenare uno sguardo sensibile, attento alle risonanze del corpo nello spazio, significa anche aprire una nuova possibilità progettuale: più umana, più equa, più autentica.